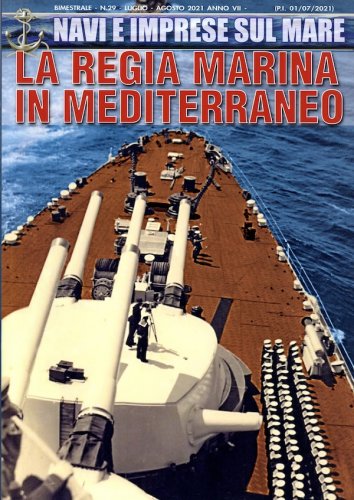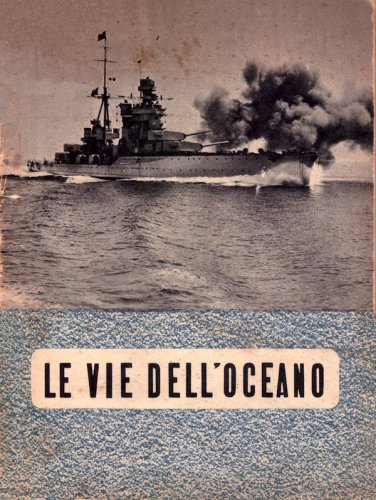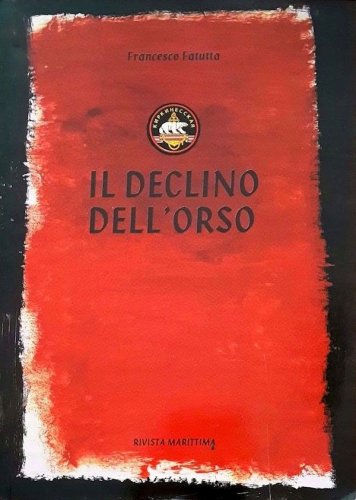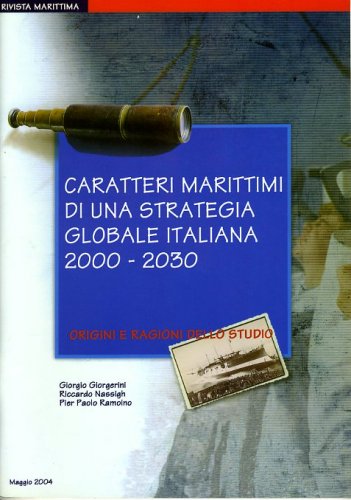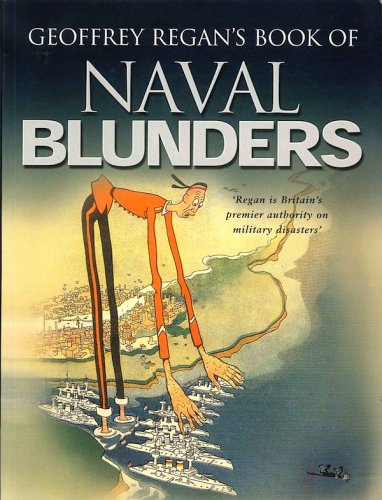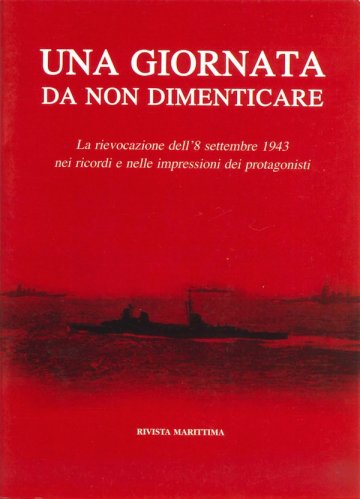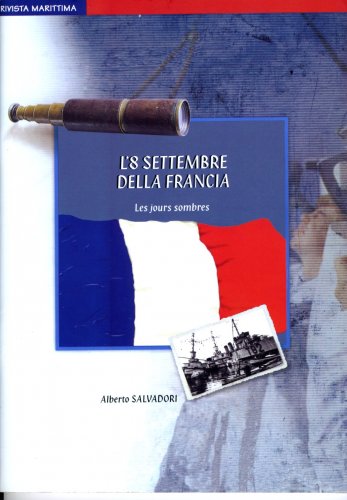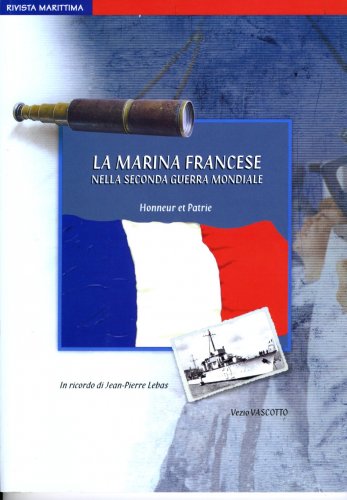Regia Marina in Mediterraneo
Regia Marina in Mediterraneo
Sgarlato Alessio, Sgarlato Nico
- Disponibile in 48 ore
- Possibilità di reso entro 10 giorni lavorativi
- Transazione sicura con carta di credito, Paypal o bonifico bancario
- Spedizione tracciata con SDA
Si possono distinguere tre periodi e altrettanti atteggiamenti della Regia Marina nel Mediterraneo durante la Seconda Guerra Mondiale. Il primo coincise grosso modo con la seconda metà del 1940 e vide l'Italia per lo più vittima dell'attacco alleato o impegnata in operazioni condotte con grande incertezza; un periodo che si può considerare come la fase dell'acquisizione della consapevolezza, quella, cioè, in cui la Regia Marina prese atto che la sua flotta eccellente, per numero di unità e per potenziale bellico, non era sostenuta da un'adeguata comprensione delle tattiche e delle tecnologie della moderna guerra navale, già raggiunte invece dai suoi avversari, gli inglesi. Il secondo periodo, che durò per tutto il 1941, terminando nell'estate del 1942, vide la flotta italiana sviluppare un'efficace sinergia con i reparti aerei nazionali e tedeschi presenti sul territorio, l'introduzione timida di qualche innovazione tecnica, lo sviluppo di una capacità sempre migliore di osservare le mosse del nemico e, infine, un costante miglioramento delle proprie capacità offensive fino a conseguire poche, ma eccezionali, vittorie. Tali successi, però, ebbero quasi sempre un caro prezzo e così si giunse alla terza fase, corrispondente all'ultimo anno di guerra, in cui l’Italia, di nuovo povera di mezzi e risorse per logoramento causato dal protrarsi del conflitto tornò più o meno allo stato iniziale. Tutte queste tre fasi, però, videro le operazioni navali nel Mediterraneo svolgersi quasi sempre all'insegna della stessa esigenza bellica: portare rifornimenti in teatri operativi vicini alle basi del nemico o impedire alla Royal Navy di fare la medesima cosa. La Guerra del Mediterraneo, infatti, fu una guerra dei convogli, proprio come quella, molto più celebrata dalla storiografia e dalla letteratura, dell'Atlantico settentrionale.
Autore
Ean / Isbn
977228427029
Pagine
88
Data pubblicazione
01/07/2021